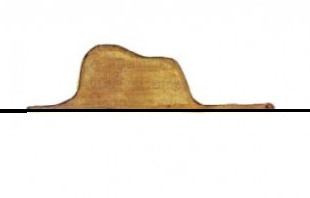|
Vincenzo Guagliardo Di sconfitta in sconfitta Considerazioni sull’esperienza brigatista alla luce di una critica del rito del capro espiatorio Colibrì edizioni 2012, 166 pagine, 12 euro isbn 88-86345-45-3 |
Ruvido e spigoloso “Di sconfitta in sconfitta” di Vincenzo Guagliardo, riedito nel maggio 2012 per i tipi della casa editrice Colibrì, non è un testo fatto per accarezzare il palato dei suoi lettori. Mi è capitato, in precedenza, di paragonare il lavoro di Vincenzo al nuotare del salmone, per sottolineare la mancanza di concessioni conformistiche dei suoi ragionamenti, il suo sapersi muovere controcorrente (o nonostante la corrente). In questo caso, se si vuole ricorrere ad una metafora animale, la più adatta mi pare essere quella dell’istrice per quanto il testo risulti difficile da maneggiare.
Si tratta però di un istrice che porta in sé una straordinaria lezione di libertà, e questo ce lo fa tenere caro. Il fatto poi che l’autore di questo saggio di libertà abbia passato gran parte della sua vita recluso ci fa tenere ancor più caro oltre al libro anche l’autore.
Nelle pagine del testo, del 2002, e nelle parole dell’intervista del 2010 che corredano questa seconda edizione, non troverà soddisfazione lo storico a caccia di fatti inediti o il giovane in cerca del passato che gli è stato celato. Il nostro paese è ancora prigioniero del processo di esorcizzazione dell’esperienza delle brigate rosse. Questa rappresenta ancora oggi, a distanza di più di trent’anni, un puntello arrugginito ma apparentemente indispensabile delle logiche securitarie e delle pratiche repressive adibite al controllo dei conflitti sociali. Il 28 maggio 2012 il prestigioso liceo classico Parini di Milano appone una targa in memoria del giornalista Walter Tobagi “ucciso dalle Brigate Rosse il 28 maggio del 1980″. In realtà, come ci ricorda Paolo Persichetti nella sua postfazione, a sparare fu un piccolo gruppo nato da una scissione delle F.C.C. (Formazioni comuniste combattenti). Gli autori di questo attentato pensavano di utilizzare la morte di Tobagi come biglietto da visita per accreditarsi con le Brigate rosse, che di Tobagi non si erano mai curate. Trentadue anni non sono bastati per dare un nome alle cose. Questa ossessione di voler trovare “un” colpevole, che si assuma il peso della storia a scapito della verità, mal permette di inquadrare raccontare e capire l’accaduto. Questa ossessione però non viene guarita da “Di sconfitta in sconfitta” che anzi si aspetta un pubblico già preparato a maneggiare più la storia che non la mitologia.
Non troverà soddisfazione il voyeur in cerca di dettagli scabrosi, di commoventi ricordi o di inedite rivelazioni. Lo stile di Vincenzo rifugge da personalismi e non concede spazio alla narcisistica contemplazione dei sé.
Non troverà soddisfazione il nostalgico in cerca di rivendicazioni, l’esercizio critico applicato alla storia delle BR concede alle cause esterne molto meno di quanto si potrebbe. Il ragionamento ha bisogno di ricostruire le fasi principali dello svolgersi di una vicenda e non di affibbiare responsabilità, le ragioni di una sconfitta vanno ricercate innanzitutto nel pensiero e nell’azione di chi la subisce.
Similmente non troverà soddisfazione il fautore del (indecoroso) ritorno all’ovile. Le ragioni della lotta non sono mai messe in discussione: è sulla sua conduzione e sulla divisione tra lottatori e spettatori che si concentra l’attenzione dell’autore.
Non resterà pago il sincero democratico, fautore di una equilibrata strada lastricata di giustizia e di buone intenzioni. La politica penale, dice Vincenzo, traghetta l’Italia al post moderno più di ogni altra cosa, facendo merce delle coscienze, delle identità e dei corpi (con l’elogio del pentimento e della dissociazione e tutta la politica penale di contorno) e polverizzando così un ricco e fertile tessuto di relazioni sociali. La giustizia penale prevede che la concretezza della materia sociale venga affidata a terzi, estranei ma tecnici preparati, i quali dotati di squadra e righello, ovvero di opportuni strumenti di misura, segnano la riga che divide il giusto dallo sbagliato, il vero dal falso, che distingue il colpevole dall’innocente. È a tutti evidente che non è mai così semplice ma a molti fa comodo dotarsi di certezze in un mondo difficile e insidioso. Non è ammesso un lato migliore, un uso più corretto del sistema penale: chi partecipa ad un sistema di questo tipo, chi ne è complice, lo sostiene anche se apparentemente lo avversa:
e proprio quest’incapacità di fronte a quanto sta dietro al sistema penale indica che esso è l’altare principale di una religione praticata e non dichiarata alla quale neppure i rivoluzionari hanno saputo finora sottrarsi. Gli eretici che si mettono a criticare soltanto l’altare non rischiano di far altro che rinnovare la religione che vi presiede. Questa è stata perlomeno finora la storia delle rivoluzioni fondate sulla violenza politica invece che su una radicale non-collaborazione alla servitù volontaria.
Ma non sarà soddisfatto nemmeno René Girard, a cui pure Vincenzo riconosce un debito nella identificazione dell’importanza del principio vittimario, del meccanismo del capro espiatorio e delle pratiche mimetiche che accompagnano la storia degli umani e dell’umanità. Girard, in fatti, è un vincente, ha trovato la sua quadratura del cerchio, il principio da cui discende ogni cosa: “le cose nascoste sin dalla fondazione del mondo”. Vincenzo, al contrario, è uno sconfitto che opera per la trasformazione, perché se è vero che la storia la raccontano i vincitori, il mutamento, però, è determinato dagli sconfitti. La sconfitta, infatti, segna il limite della conoscenza (o, potremmo dire, della coscienza?) e l’inizio della scoperta. È la fine del noto e l’inizio dell’essenza della materia sociale cui ancora non sappiamo dare un nome, è una misura dei nostri errori, che ci insegnano sempre molto più che le nostre vittorie. Questo vale nel cammino della storia, segnato da conflitti di rilevanza diversa ma tutti, in una certa misura, concorrenti a determinare l’evolversi degli eventi. Come vale nel progredire delle conoscenze (delle scienze) costantemente messe di fronte allo scontro con l’ignoto, scontro da cui ne escono solo riconoscendo l’impossibilità di sovra determinare (dominare) la materia insieme alla necessità di trovare un accordo tra la sua rappresentazione e l’evidenza sperimentale.
Ma come l’elaborazione dell’ipotesi scientifica non può essere un fatto individuale, così l’esperienza conoscitiva del conflitto vale tanto più quanto più è frutto di un processo collettivo, e ciò è vero anche per la ricostruzione della sconfitta. Uno degli effetti della pratica di eleggere dei capri espiatori per sacrificare le nostre – potenziali – colpe o per sfogare le nostre pulsioni, è quello di definire un’identità collettiva di riferimento. Noi siamo noi perché NON siamo la vittima sacrificale NE’ siamo coloro che si oppongono al rito. La simbologia del sacrificio introduce un livello di superstizione nella rappresentazione della realtà che definisce delle aree di appartenenza su una base simbolica: il branco. E, guarda caso, il gruppo così identificato è, rispetto alla vittima sacrificale, assolutamente vincente, e lo è tanto più quanto più la vittima è innocente, a misura della potenza del rito. La proposta di Vincenzo è quindi tra le più difficili: che il collettivo si riconosca come sconfitto (come inevitabilmente sconfitto) e che tragga così dal suo essere collettivo ragionante non delle identità ma delle conoscenze, indispensabili affinché la sconfitta successiva sia un po’ più innanzi, nella giusta direzione. Come è ovvio questo non va confuso con le pratiche di abiura o pentimento in cui lo sconfitto cede financo le proprie ragioni, ma anzi vuole essere un esempio di una pratica di non-collaborazione che ha esattamente lo scopo di non volersi identificare con ciò che si avversa.
Nella sua narrazione diversi sono i collettivi che si succedono: il collettivo dei brigatisti, quello dei giudicanti, e quindi quello degli abiuranti. Dei tre il primo si è dissolto, vittima di un vuoto del collettivo prima ancora che della sconfitta politica-militare. I secondi due partecipano al rito sulla base di un copione noto e inutile, non aiutati da una storia recente di tale pochezza da non permettere di dare un nome alle pratiche attuali della lotta sociale senza doversi rifare alla mitologia del passato. (e che non ha ancora saputo fare i conti con quel pugno di testimoni che ancora restano reclusi o esiliati, dimenticati dall’indifferenza generale)
Il libro di Vincenzo è un atto di libertà quando propone di disfarsi dello schema identitario per poter affrontare, collettivamente e meglio, i conflitti, frutto di disequilibri e contraddizioni che non sappiamo, perché non vogliamo, dominare. Quello del dominio, di fatti, non è il nostro mestiere.
Quindi, per non cascare nell’uso mimetico della violenza, la quale identifica il combattente con il combattuto e riproduce il guaio che vorrebbe evitare (la violenza fa sì che trovi voce solo quel che c’è, non quel che dovrà esservi), V. propone la pratica della non-collaborazione: in guerra disertare esercitando delle pratiche che si avvicinano alla meta anziché rimandare tutto a un domani.
È chiaro che se accetto la violenza ma poi collaboro a quel sistema che combatto, là dove non si è arrivati alla condizione estrema della difesa immediata della propria vita e della propria dignità, allora ecco che lì il ricorso alla violenza può diventare l’alibi della non messa in discussione di tutto ciò che pretendi di combattere.
Sia detto per inciso ma a parere dello scrivente il giudizio dell’autore sui protagonisti degli eventi che descrive è fin troppo severo. Non possiamo (e non dobbiamo) dimenticare che le vicende di cui parla vanno inquadrate in un contesto affollato di collettivi, liberi e alla ricerca di una strada più giusta di quanto si fosse sperimentato fino ad allora. Questo contesto di coralità non sempre assonanti ha inevitabilmente molto a che fare con la storia delle brigate rosse. Non è quindi allo scopo di attribuire delle responsabilità o delle sfortune che si deve misurare il contributo delle cause interne con quello delle cause esterne ma perché a una articolazione delle relazioni come quella che vi fu in quegli anni va riconosciuto il suo peso. La ricostruzione della parabola delle brigate rosse, così stilizzata, serve qui piuttosto come esempio di autofagogitazione del conflitto di classe ed è, quindi, un paradigma assolutamente ripetibile, come l’intervista pubblicata in calce vuol ribadire.
Pur nel suo radicalismo Vincenzo Guagliardo non è apodittico, non offre soluzioni, si limita a fare degli esempi:
se proprio si vuole essere un “antifascista” dei nostri tempi si dovrebbe ospitare un extracomunitario a casa propria, ad esempio
lasciando aperto il campo delle possibilità delle pratiche di non-collaborazione e della loro articolazione nella lotta per una società diversa perché migliore.
Sarà per tutto questo che “Di sconfitta in sconfitta” fa così fatica ad uscire, come per altro è stato per il suo autore?
tommaso agosto 2012
[p.s. Nella politica dei conflitti è buona norma affrontare la rappresentazione dei soggetti coinvolti e dello scopo che si propongono, nel breve e nel lungo periodo. Ereditiamo dalla storia, su questi aspetti, una serie di schemi consolidati, anch’essi un po’ stilizzati, ma funzionali. Intervenire sulle esperienze del passato per affinare la conoscenza e gli strumenti potrebbe richiedere una ridefinizione anche di queste categorie.]