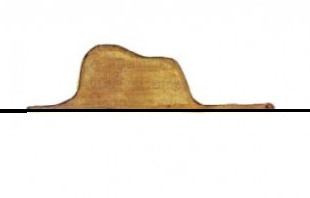Il libro dell’incontro
Vittime e responsabili della lotta armata a confronto
[il Saggiatore, Milano, 2015]
NOTE A MARGINE
Per l’ennesima volta alzò lo sguardo. I grappoli pendevano pesanti, quasi a voler trascinare a terra i rami. Gli acini rossi manifestavano col loro turgore l’inarrestabile forza della natura.
Meditò ancora, soppesò i garretti, misurò di sottecchi la distanza e nuovamente capì che non ce l’avrebbe fatta.
Sapeva che non era in assoluto impossibile, ma capiva che non era più affar suo, non in quel momento. Si sentiva stanca, la ferita le faceva male e quella lunga attesa sembrava aver cristallizzato i sogni trasformandoli negli incubi peggiori.
Non fu facile ammetterlo né farsene una ragione. Tanta fatica aveva fatto per arrivare fin lì.
Lasciò spazio al tempo, in attesa che accadesse qualcosa, ma tutto era fermo. Il mondo, per lei, sembrava essersi fatto di marmo.
Così, quando le parve meglio, senza guardarsi troppo attorno, si alzò e si incamminò verso la città. “Non era neanche buona” la sentirono mormorare.
~~~~~~~~ * ~~~~~~~~
Un processo di estraniazione
Nel periodo intercorso tra la fine degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, in Italia avvenne un fatto notevole, di cui però la memoria conserva oggi solo labili tracce: una generazione appassionata di politica, che si era dedicata anima e corpo alla trasformazione del mondo, fu vittima di un processo di estraniazione (o di svelamento a seconda dei punti di vista) che la portò a rompere col proprio recente passato e a imboccare una strada destinata a condurla di là dal fosso che l’aveva, fino a poco prima, separata dall’avversario.
Fu un salto triplo con un atterraggio finale in un campo più “neutro”, ove non proprio “amico” del proprio “nemico”.
In un contesto che andava profondamente mutando anche a livello internazionale, la crisi e la ristrutturazione del comparto produttivo nostrano avevano iniziato a falcidiare gli operai delle grandi fabbriche, mentre la repressione si era fatta molto dura. Torture, abusi e leggi speciali mettevano all’angolo i portatori di spinte al cambiamento che erano state vaste e profonde. Un uso spregiudicato del diritto preannunciava una loro carcerazione sine die.
Dall’altra parte, anche tra chi ancora perseguiva un progetto di radicale trasformazione della società, il nervosismo era crescente. I toni non solo si erano alzati, ma lo scontro si era spostato al bordo del ring. Da ambo le parti non si risparmiavano colpi sotto la cintura.
L’esercito della salvezza, sceso in campo al servizio del piccolo e grande capitale, era senza pari: vi si trovarono riuniti i militari, i partiti dell’arco parlamentare, le loro appendici ex extraparlamentari, i media. Perfino un noto quotidiano comunista ebbe una parte non da poco nell’opera di calmieraggio della spinta insurrezionale. La classe media, che sarebbe stata sacrificata di lì a poco al moloch del capitale multinazionale, sostenne attivamente i crociati della repressione sociale fomentandoli, nutrendoli, cantandone le lodi. Non immaginava che, legittimando, in virtù dell’emergenza, una sistematica deroga alle regole della “Repubblica nata dalla Resistenza”, stava intrecciando il cappio che avrebbe finito per strangolarla? Comunque sia stato resta che tale deroga entrò a far parte di una nuova “costituzione materiale” che oggi costringe la società tutta a vivere nel panoptico di una sorveglianza speciale.
Non fu una cosa da nulla.
Chi si trovò in questi frangenti nelle mani di sgherri e aguzzini (e non furono pochi) dovette porsi più di una domanda e inevitabilmente cercò di darsi delle risposte. I più deboli o volenterosi (a seconda dei punti di vista) denunciarono i proprî fratelli.
I più timidi e incerti non aspettarono comunque troppo prima di rivolgersi al boia (e alla stampa) per ammettere che il loro era stato un grosso errore.
Benvenuti, è l’alba degli anni ’80.
Non ci interessa qui dettagliare le gradazioni dell’abiura, né misurare la profondità con cui la lama fu affondata nel corpo del fratello, basti sapere che dai discorsi di chi aveva preso queste strade scomparvero parole come sfruttati e sfruttatori, mentre quell’urgenza da cui era scaturita una radicale rottura col presente si stemperò nella mite prospettiva di un miglioramento, auspicabile, quando possibile, ma senza pretesa alcuna di minacciare la validità degli assetti di potere esistenti. Le intelligenze, i valori, la generosità e il coraggio cedettero il passo a un mercimonio delle coscienze. Si fece a gara a mostrare resipiscenza cercando di non risultare troppo meschini agli occhi proprî e dei proprî amici. Si arrivò persino a consegnare le armi, in segno di buona volontà.
Per i pentiti fu varata una legge ad hoc nel maggio del 1982.
Restava fuori chi quella figura non la voleva fare, chi non era pronto a barattare la sua libertà con la prigionia altrui.
L’unica formula alternativa alla delazione che ebbe successo fu quella detta della dissociazione. Questa tecnicamente prevedeva tre cose:
– l’ammissione delle «attività effettivamente svolte»
– «comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo»
– il «ripudio della violenza come metodo di lotta politica»
Il dissociato si distingueva dal pentito perché le sue parole, apparentemente, non mandavano in galera nessuno. Ma anche in questo la scelta della dissociazione non fu così lineare.
Andò, infatti, che chi si dissociava venisse “premiato” per aver intrapreso una strada collaborativa, mentre chi sceglieva il normale atteggiamento dell’imputato, tanto normale da stare alla base stessa del procedimento penale, venisse automaticamente fatto rientrare nella categoria dell’“irriducibile”, con tutte le conseguenze del caso.
Andò che lo stesso criticare l’istituto della dissociazione o chi se ne era avvalso divenisse motivo di sospetto e arrivò persino a costituire un vero e proprio elemento d’accusa.
Andò che le ammissioni dei dissociati ricadessero come atti d’accusa impliciti nei confronti dei coimputati. [Se di cinque imputati tre ammettono gli addebiti, sarà più difficile per i restanti due difendersi.]
Andò che formalizzare la figura del collaborativo servisse a stigmatizzare quella dell’ostile, che l’apertura di spazi carcerari per il primo permise la riduzione dei diritti per il secondo, col risultato di aumentare la temperatura delle galere rendendo ancor più forte la pressione sui soggetti reclusi.
Una collaborazione, quella dei “dissociati dal terrorismo”, che veniva spacciata in termini giuridici come frutto di una scelta ‘individuale’ di ripensamento ma che in realtà interessava solo in quanto scelta ‘collettiva’, come collettivo era lo scontro:
Dice Silvio Coco, senatore democristiano, al Convegno sulla “Legislazione premiale” organizzato dal Centro studi “Enrico De Nicola” a Courmayeur il 19 aprile 1986 illustrando ai colleghi il disegno di legge sulla dissociazione:
«[…] questi uomini delle aree omogenee non soltanto hanno un atteggiamento intellettuale di rifiuto della ideologia della lotta armata, che è pure importante per la preminenza dello Stato e della legalità democratica, ma nelle carceri soprattutto si sono fattivamente adoperati contro quegli altri che si chiamano irriducibili e che continuano la loro attività di reclutamento, la loro attività di suggestione, la loro attività di collegamento con gli altri che sono fuori. Quindi non si ha preminentemente un fatto intellettuale o culturale ma si ha un comportamento che può essere, deve essere rilevante ai fini penali».
La legge premiale sulla dissociazione fu approvata nel febbraio 1987 e si applicava «solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983». Si configurò quindi come un saldo di pagamento a beneficio di coloro i quali avevano dimostrato, anni prima, tanta operosa buona volontà, una sorta di assegno postdatato che andava infine all’incasso.
Ha luogo, in questo periodo, un processo di trasformazione del pensiero penale che in Italia ha come manifestazioni evidenti, oltre a quella testé ricordata sulla dissociazione, la “legge Gozzini”, che sancisce, generalizza e incorpora stabilmente nell’ordinamento penitenziario quella differenziazione di trattamento dapprima sperimentata con le figure del “dissociato” da una parte e dell’“irriducibile” dall’altra.
Michel Foucault nel corso di Lovanio del 1981 (lezione del 20 maggio) con occhio lungimirante scrive:
Abbiamo in questo un punto importante da segnalare nella storia del pensiero penale: è il momento in cui la domanda di confessione […] si trova rimpiazzata e sostituita da una domanda di un altro genere. Non si tratta più per il giudice di dire quello che, implicitamente, diceva un tempo: «Dimmi se, effettivamente hai commesso il crimine di cui sei accusato. Dimmi se, effettivamente, riconosci nella tua volontà fondamentale la fondatezza e la legittimità della condanna che pronuncerò contro di te». Ora il giudice pone implicitamente a colui che è accusato la domanda: «Dimmi chi sei, perché io possa prendere una decisione giudiziaria che dovrà essere commisurata certamente al crimine che hai commesso ma anche, al contempo, all’individuo che tu sei».
I prigionieri, dissociati e i resipiscenti del post dissociazione, furono fatti salire sul palco per dichiarare che la guerra era finita, benché la loro condizione rendesse stonate e poco credibili le loro parole.
Qualcuno rimase (fuori e dentro le galere) sulla vecchia strada, ma dovette imparare che anche questa era cambiata, si era fatta più impervia e solitaria.
Oggi, a distanza di trent’anni, questa vicenda riecheggia in un libro che narra di un decennio di incontri tra alcuni protagonisti (volenti o nolenti) di quello che fu il maggiore sforzo insurrezionale del secondo dopoguerra in un Paese a capitalismo avanzato.
Il libro dell’incontro
Vittime e responsabili della lotta armata a confronto (1)
Si tratta della più recente e autorevole tappa di un percorso che iniziò – appunto – nei primi anni ’80 a opera di diversi cappellani delle carceri sotto l’ala dell’allora arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini.
In questo lungo lasso di tempo, con diverse modalità, prese corpo un dialogo tra alcuni ex militanti delle organizzazioni rivoluzionarie, più o meno armate, e alcuni pezzi della cosiddetta “società civile”, che portò in primis alla riforma penitenziaria del 1986 (“legge Gozzini”) e quindi alla legge sulla dissociazione (1987).
La “legge Gozzini” introduce il concetto di premialità nell’ordinario trattamento penitenziario e nelle modalità di accesso accesso ai benefici di legge. Viene estesa all’intero corpo carcerario la distinzione tra il regime più “aperto” delle “aree omogenee”, create per ospitare i dissociati, e quello più “stretto” del carcere duro, altrimenti noto come “circuito dei camosci”(2).
A un comportamento “retto” corrispondono maggiori benefici. Naturalmente la mera reazione alle angherie del sistema penitenziario non può essere vista come un segno di collaborazione, quindi si fa presto a restare fuori dalla conta dei buoni. I benefici sono concessi a chi collabora con l’istituzione, a chi non costituisce un problema per l’istituzione carceraria e per la società esterna. La “legge Gozzini” ha l’effetto di rompere la comunità dei detenuti comuni, come il dispositivo della dissociazione aveva rotto quella dei detenuti politici.
La parola d’ordine degli anni ’80 fu, per usare una formula riassuntiva, “frantumare per governare”.
La legge sulla dissociazione, per parte sua, è una strana legge. Non introduce elementi di diritto, non stabilisce una norma valida nel tempo. Con essa si concedono considerevoli sconti di pena a chi, accusato di delitti commessi entro la fine dell’anno 1983 (cioè ben quattro anni prima della sua approvazione), si sia allontanato dalle pratiche della lotta armata e dall’organizzazione di appartenenza. Più che una norma di diritto, come si è detto, è un riconoscimento per coloro i quali si sono attivamente occupati a rompere il fronte dei detenuti politici. Avrà effetti addirittura più devastanti della delazione che portava alla cattura dei militanti in libertà.
In questa prima fase il ruolo svolto dalla Chiesa è consistente.
I cappellani hanno accesso alle strutture carcerarie, parlano sia con i detenuti sia con chi sta all’esterno. La teoria del perdono ha (insieme al suo contrario) un posto importante nell’assetto dottrinario del cristianesimo. Ampi settori del mondo cattolico, come anche di quello valdese, si posero in prima fila nella mediazione tra detenuti politici e Stato.
Il cardinale Martini tiene un capo del filo (è a lui che i militanti dissociati dei CoCoRi consegneranno tre borse piene armi nel giugno del 1984) e dà vita a un gruppo che comprende inizialmente detenuti ma che poi si allarga alle “vittime” (e soprattutto ai parenti di alcune delle “vittime”) della stagione di lotte che arriva fino ai primi anni ’80.
Questo testo, in particolare, è il frutto di una serie di incontri, discussioni e scambi all’interno di un gruppo la cui attività può considerarsi il proseguimento del lavoro di Martini e che inizia il suo percorso alla fine degli anni ’90 (quindi in grandissima parte riguarda persone non più detenute).
Oggi, a distanza di trent’anni, quando ancora chi allora passò per le mani dei torturatori di Stato sconta la sua interminabile pena, quando le idee e le speranze di cambiamento giacciono irrise e dimenticate, quando una generazione lobotomizzata è costretta ad arrabattarsi tra precarietà e lavori non pagati cercando la propria immagine in una teoria di specchi che riflettono il nulla denominato presente, vale la pena di chiedersi chi sono queste “vittime e responsabili della lotta armata” di cui parla il sottotitolo del libro. O quantomeno vale la pena di dichiarare a che prezzo si acquisisce il diritto di sedere a quel tavolo.
Terminologia (nomina nuda)
Per “vittime” gli autori intendono chi fu ferito o ucciso (in questo caso il riferimento è ai parenti diretti) a opera delle organizzazioni armate negli anni ’70-80. Unica eccezione risulterebbe essere quella di Anna Negri, figlia di Antonio, che assurge miracolosamente al rango di “vittima” grazie al suo libro “Con un piede impigliato nella storia” (3). Non vi è, viceversa, Manolo Morlacchi, figlio di Pierino e Heidi Ruth Peusch, che evidentemente, nelle pagine del suo romanzo-testimonianza, non si mostra abbastanza contrito (4).
Nel testo poi i “responsabili della lotta armata” sono alcuni ex militanti che si sono avvalsi della legislazione premiale (dissociati o beneficiati dalla “Gozzini”) e che hanno già da tempo saltato politicamente il fosso.
Il libro parla di un percorso di riconciliazione, un percorso apprezzabile e anche per certi versi auspicabile a titolo personale e individuale, finché, per qualche ragione non spiegata, non aneli a farsi pubblico. Per questo scopo il campionario dei soggetti delegati ad approfondire la “comprensione della storia”, di una storia non trascurabile del nostro (e non solo) Paese, risulta infatti alquanto limitato.
Non ci sono i parenti delle vittime delle stragi (5), la moglie e le figlie di Pino Pinelli, il quale risulta ancora, agli occhi della storia appunto, deceduto a colpa di un “malore attivo”.
Non sono da ritenersi vittime Mara Cagol, freddata con un colpo a bruciapelo durante l’operazione che portò alla liberazione di Vittorio Vallarino Gancia; non lo è Francesco Berardi, morto suicida in prigione dopo essere stato denunciato dall’operaio e sindacalista Guido Rossa; non ci sono i parenti di Mauro Larghi, ventunenne ucciso di botte a San Vittore, né quelli di Annamaria Ludmann, Riccardo Dura, Lorenzo Betassa e Piero Panciarelli, sorpresi nel sonno e ammazzati dai carabinieri in via Fracchia il 28 marzo 1980.
Non sono vittime Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Marino Serri, Afro Tondelli, Emilio Reverberi, Saverio Saltarelli, Francesco Lorusso e tutti gli altri uccisi nelle piazze dalle forze dell’ordine.
Non è vittima Cesare Di Lenardo, torturato in questura dalla squadretta di Nicola Ciocia (questore poi divenuto avvocato), Salvatore Genova (poi parlamentare PSDI) al diretto comando del ministero degli Interni.
Non sono vittime degne di parola i morti d’amianto, i bambini coi volti deturpati dalla diossina dell’Icmesa, né gli oltre duemila morti sul lavoro censiti ogni anno e quelli non censiti.
L’elenco sarebbe ancora lungo.
Così non sono tra i responsabili le migliaia di persone che affollarono le lotte degli anni ’70 nelle scuole, negli ospedali, nelle fabbriche, senza le quali nessuna organizzazione armata sarebbe potuta sopravvivere per più di qualche mese.
Non sono da ritenersi convitati in quanto responsabili degni di parola neppure coloro i quali non hanno abiurato o misconosciuto il loro passato o coloro i quali alla metà degli anni ’80 hanno deciso di non fermarsi.
Non abbiamo l’elenco completo di chi si è seduto al tavolo della conciliazione, ma dalle loro parole risulta che quest’altra folla ne è rimasta esclusa, senza che alcuno degli invitati ne sentisse la mancanza.
Sono invece classificati tra i responsabili degni di parola alcuni fascisti (“ex appartenenti della destra eversiva”) che operarono al soldo e sotto la copertura dei servizi segreti dello Stato italiano, anche se della cosa nel testo non si fa menzione.
Una scelta, se di scelta si può parlare, nel suo complesso tendenziosa, che poco favorisce un lavoro serio di ricostruzione, lasciando invece trapelare finalità politiche per nulla riconciliatorie, anzi tese a rimarcare il punto di vista dei vincitori e quello solo.
Timonieri, che, nelle intenzioni, sono addetti alla guida, ma non capitani che decidono la rotta, sono Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato. I tre mediatori che hanno seguito questa vicenda si ispirano a quanto avvenne in Sudafrica all’inizio degli anni ’90 benché lo definiscano come “non assimilabile a questa esperienza”. Per fortuna. Lì infatti qualcosa di grosso era effettivamente avvenuto, vi era stata una radicale rottura con il passato e il regime dell’apartheid era stato sconfitto. Si era cioè determinata una rottura dell’assetto sociale seguita da una inversione dei ruoli e degli assetti di potere. E fu per placare la sete di rivalsa degli oppressi che si optò per un processo aperto all’esposizione delle nefandezze e atrocità compiute da entrambe le parti, come precondizione per il godimento di una misura di amnistia.
Nel nostro caso, invece, è come se Mandela, nel corso della sua quasi trentennale prigionia, a un bel momento avesse confessato a Botha di aver capito di essersi sbagliato – col suo movimento di lotta, le sue assurde pretese e le violenze inestricabilmente connesse – e il capo del regime dell’apartheid, nel pieno dei suoi immutati poteri, gli avesse concesso, bontà sua, il perdono, una volta scontata la pena.
Invece scrive Mandela:
Alle prese con i disordini interni e con le pressioni internazionali, P.W. Botha avanzò una tiepida proposta: il 31 gennaio 1985, durante un dibattito parlamentare, affermò pubblicamente di essere disposto a liberarmi se respingevo “incondizionatamente la violenza come strumento di lotta politica”. L’offerta era estesa a tutti i detenuti politici. Poi, come per sfidarmi pubblicamente, soggiunse: “Adesso non è quindi il governo sudafricano che si oppone alla liberazione del signor Mandela, ma lui stesso”.
[…]
Diedi a Ismail e Winnie il testo del discorso che avevo preparato. Oltre a rispondere al governo, volevo ringraziare pubblicamente l’Udf per il suo ottimo lavoro e congratularmi con l’arcivescovo Tutu per il Premio Nobel, aggiungendo che questo riconoscimento andava tributato a tutto il popolo. Domenica, 10 febbraio 1985, mia figlia Zindzi lesse la mia risposta [alla proposta di Botha] davanti a una folla acclamante di persone che non avevano potuto sentirmi parlare legalmente in Sudafrica per più di vent’anni.
Zindzi era un’oratrice incisiva come sua madre, e disse subito che suo padre avrebbe dovuto essere allo stadio per pronunciare personalmente il discorso. Fui orgoglioso di sapere che era stata lei a pronunciarlo.Sono un militante dell’African National Congress. Lo sono sempre stato e lo sarò sempre fino al giorno della mia morte. Oliver Tambo è più che un fratello per me. È il mio più caro amico e compagno da quasi cinquant’anni. Se qualcuno di voi ha cara la mia libertà, Oliver Tambo l’ha ancora più cara, e so che darebbe la vita per vedermi libero…
Sono sorpreso per le condizioni che il governo vuole impormi. Non sono un violento… Soltanto nel momento in cui qualsiasi altra forma di resistenza ci è stata preclusa abbiamo preso la strada della lotta armata. Se Botha vuole dimostrare di essere diverso da Malan, Strijdom e Verwoerd, deve rinunciare alla violenza, deve impegnarsi ad abolire l’apartheid, deve riammettere nella legalità l’organizzazione del popolo, l’African National Congress; deve riabilitare tutti coloro che sono stati incarcerati ed esiliati per la loro opposizione all’apartheid, deve garantire la libera partecipazione politica così che il popolo possa eleggere i propri governanti.
La mia libertà mi sta a cuore, ma mi sta ancora più a cuore la vostra.
Troppe persone sono morte da quando sono stato incarcerato, troppe hanno sofferto per amore della libertà. Di essa sono debitore alle vedove, agli orfani, ai genitori che hanno pianto e portato il lutto per i loro cari. Non sono stato il solo a soffrire in questi lunghi anni perduti e solitari. Amo la vita non meno di voi, ma non sono disposto a barattare il mio diritto, né il diritto della gente a essere libera…
Quale libertà mi viene offerta se l’organizzazione del popolo rimane fuori legge? Quale libertà mi viene offerta se posso essere arrestato per la violazione di un permesso? Quale libertà mi viene offerta di vivere una vita familiare se la mia cara moglie è ancora confinata a Brandfort? Quale libertà mi viene offerta se per vivere in un’area cittadina devo richiedere un permesso? Quale libertà mi viene offerta se proprio i miei diritti di cittadino sudafricano non sono rispettati?
Soltanto gli uomini liberi possono negoziare, i detenuti non hanno potere contrattuale… Non posso e non voglio assumere alcun impegno finché io, – e voi, mio popolo – non saremo liberi. La vostra libertà e la mia non possono essere divise. Ritornerò in mezzo a voi (6).
Paradossalmente questo lavoro non contribuisce alla memoria neanche di coloro che vi partecipano in veste di responsabili poiché, anziché liberarli dalla mostrificazione, ottiene l’effetto contrario, confermandone la natura (allora) mostruosa, benché (oggi) redenta.
Qual è lo scopo di un’opera che nel suo cammino si arricchisce di un nutrito codazzo di garanti, uomini e donne pubblici e “puliti”, che aiutano a dissipare le ultime tracce di “sporco”, questi sì, disposti a metterci il nome e la faccia?
Se da un lato è ben visibile un’esigenza di riconciliazione individuale da parte di chi, sconfitto, ha consegnato se stesso e la sua storia nelle mani del vincitore, dall’altro si cancellano le ragioni storiche del conflitto che allora prendeva vita, ragioni peraltro non certo scomparse anzi, per molti versi, fattesi ancor più acute. L’effetto complessivo è quello di “ridurre” il piano collettivo degli eventi storici costringendolo a forza nel letto di Procuste dei destini individuali.
Il dissidio (facciamo un esempio)
Verso la fine del testo un saggio di Adolfo Ceretti, “Lotta armata, vittime, conflitti e dissidi. Un’ultima ricognizione”, descrive un caso di inapplicabilità della giustizia, il conflitto irriducibile, altrimenti detto dissidio.
Il dissidio è così descritto da Ceretti:
– “gli interessi sono contrastanti, e sono orientati a un sistema di riferimenti – principi etici/morali, giuridico costituzionali o abiti di comportamento – non condivisi”;
– “la dimensione e il peso degli interessi confliggenti, nonché la forza e il potere degli attori si presentano come non comparabili, perché nettamente asimmetrici e potenzialmente non-reversibili”;
– “le istanze di dominio di una parte sono egemoni”.
Pensando alla storia parrebbe si voglia parlare del noto “dissidio” tra il Capitale e il Lavoro, motore primo di gran parte delle tensioni del secolo passato.
Invece no, qui non si guarda al contesto che fu (e che nella sostanza ancora è), al momento in cui il conflitto prende corpo e si muove; non ci si riferisce alla lotta di classe, allo scontro tra i potenti e i “dannati della terra”, all’immensurabile asimmetria di mezzi tra sfruttati e sfruttatori… no. Qui ci si riferisce a quello specifico (e piccolo) pezzo del presente costituito dal rapporto tra “responsabili” e “vittime” (7) (nelle accezioni descritte in precedenza). Ceretti sostiene che essendo il dissidio un confronto irriducibile, in cui mezzi e linguaggi sono così diversi da costituire un vuoto incolmabile da parole o gesti, si arriva necessariamente a identificare lo strumento del perdono come atto unilaterale extra storico (benché soggettivamente molto forte):
Il perdono, laddove c’è dissidio, non può che intervenire a latere dei contendenti. Ognuno rimane iscritto nel suo passato (immemorabile per l’altro), nella sua lingua nella sua storia. Si accetta di perdonare sapendo che tale irriducibilità non verrà meno (8).
Sembra di avere di fronte un gatto che si morde la coda. La soggettivazione della memoria, la decontestualizzazione rispetto al quadro storico, sociale e politico, l’uso di vicende individuali come specchio della storia, addirittura il tentativo di derivarne nuovi strumenti giuridici, tutto ciò “impaglia” gli attori – anche questi due attori viziati: le “vittime” e i “responsabili” – in un ruolo infine incomprensibile, in una tensione che si consuma a vuoto e da cui si può uscire soltanto con una presa di posizione unilaterale intesa a ricostruire il quadro d’insieme. Con che, colui che ha già perso è costretto a farlo per una seconda volta.
Sembra che si voglia qui ricondurre a un unico pensiero le parti di un dissidio (dissidio, nell’accezione descritta prima, è un termine gentile ma rende l’idea) che sono state espressione di necessità differenti, bisogni incompatibili, futuri non condivisibili, e che avevano, in più, effettivamente un’asimmetrica dotazione di mezzi nell’accesso non tanto alla conoscenza quanto agli strumenti di trasformazione del mondo. Dovrebbe essere del tutto inutile spiegare l’oggettivazione del ruolo del lavoratore salariato (poco importa se a una catena di montaggio o in una software house) che riassume e pesa come un macigno sulle spalle di un esercito di donne e uomini al servizio della ricchezza altrui. Forse potrebbe essere interessante stabilire un confronto con quel passo del libro in cui si biasima l’oggettivazione della “vittima” che vede l’uomo trasformato nella sua funzione (9). Non dovrebbe essere difficile capire che la contraddizione tra chi vende e chi compra forza-lavoro è insanabile, parla lingue diverse e mostra tale disparità di mezzi da imporre l’uso della violenza da entrambe le parti. È questo un dissidio oggettivo (e non soggettivo come quello degli anni ’90 cui Ceretti affida la ricomposizione di un’etica da Seconda Repubblica) con cui i soggetti hanno, e dovrebbero ancora saper fare, i conti.
Ancora non si vuole riconoscere che scontro vi fu (e, benché meno acceso nelle sue manifestazioni, c’è ancora). Ancora al conflitto di classe si contrappone una normalità migliorabile minata dalla sconsideratezza di qualche soggetto, punibile in quanto soggettivamente colpevole.È solo accettando di comprendere la natura generale del conflitto, pur senza necessariamente condividerla, che si restituisce dignità alle persone e ai fatti e si comincia a fare storia. L’assunto aprioristico che vi siano dei responsabili e delle vittime può produrre solo una visione macchiettistica dei rapporti sociali, delle dinamiche storiche e financo di quelle interpersonali.
Concludendo
Per concludere va detto che nel libro c’è più di questo.
C’è, per esempio, il racconto di alcune toccanti vicende umane.
C’è la descrizione del lodevole tentativo di immaginare approcci diversi alla giustizia penale (immaginare solo, beninteso, perché le pratiche che il libro racconta avvengono tutte a valle del giudizio e dell’espiazione della pena, quindi sostanzialmente a giochi fatti).
C’è una interessante descrizione del rib, un approccio biblico alla risoluzione del conflitto, un po’ più pragmatica del “chi non è con me è contro di me” dell’apostolo Luca, e senz’altro meno astrusa del “three strikes and you’re out” statunitense.
C’è un’attenta descrizione del lavoro della Truth and Reconciliation Commission sudafricana; peraltro come si è già detto gli Autori, che ribadiscono costantemente come le due esperienze siano incommensurabili, non chiariscono mai in cosa consista questa differenza, cosa che avrebbero potuto fare citando, per esempio, tre semplici dati di fatto:
– la TRC costituiva una reale alternativa alla giustizia penale;
– la TRC è stata voluta dalla parte vincente in un conflitto reale, violento e prolungato, di portata storica, che aveva imposto una radicale trasformazione degli assetti di potere vigenti nel Paese,
– la TRC si apriva all’esame delle responsabilità di tutte le parti in conflitto senza imporre una classificazione aprioristica tra vittime e responsabili e che, proprio per questo, poteva essere un utile strumento per la comprensione del conflitto e della storia recente.
C’è un intero capitolo dedicato alla descrizione della storia della legislazione premiale in cui si intravedono le tensioni che si produssero, in quegli anni, tra i poteri dello Stato: legislativo, giuridico ed esecutivo (aspetto interessante della vicenda di cui raramente si fa menzione).
Infine non c’è un ebook ma solo la scritta “L’ebook con i contenuti extra del libro sarà disponibile per il download a breve da questa pagina. (http://www.ilsaggiatore.com/?s=il+libro+dell%27incontro)
~~~~~~~~ * ~~~~~~~~
La volpe tornò in città, ma anche lì non seppe darsi pace. Si fece degli amici che le volevano bene. Con loro parlava di quel che era successo ma questo non bastava a placare la sua smania, e non bastava ancor più agli amici, che l’avrebbero voluta uguale pur sapendo che non lo sarebbe mai stata. Alla fine stabilirono, col supporto di una comunità di dotti, che l’uva era da considerarsi dannosa e che mai nessuno l’avrebbe dovuta mangiare più. Trasformarono così la rinuncia in un atto di coraggio da insegnare alle generazioni a venire.
Ommot, luglio 2017
(1) Nel testo si fa un costante riferimento a un ebook che lo dovrebbe affiancare. Purtroppo questo ebook ci è risultato introvabile, ogni commento che segue risente quindi di questa lacuna originaria. Peccato.
(2) Oggi trasformatosi nei vari regimi di Alta Sorveglianza e nel 41bis.
(3) Suo padre, Antonio Negri, invece non c’è. Strano perché, se forse fu responsabile, senz’altro fu vittima di una macchinazione giudiziaria che lo vide accusato (insieme a tanti) dei più improbabili reati allo scopo di colpire il ventre molle di quel ricchissimo, eterogeneo ma un po’ inconsapevole e impreparato movimento che animò le piazze nel 1977. Gli fu teso un tranello, in cui il professore cascò rovinosamente, diventando il primo dissociato della storia nazionale.
(4) Questo aspetto lascia trasparire il dubbio che la “vittimarietà” del parente sia più lo specchio di una percezione individuale dello stesso che un carattere oggettivo legato alla dinamica dei fatti (cosa che per il ferito o l’ucciso non si può dire). Sarebbe necessaria una riflessione sul peso che il ruolo del parente della vittima ha assunto nel nostro ordinamento giudiziario e nella argomentazione comune e sul «paradigma vittimario asimmetrico» in generale.
Per quanto riguarda Manolo Morlacchi, il suo libro La fuga in avanti. La rivoluzione è un fiore che non muore (Agenzia X, Milano, 2007) diviene elemento probatorio in una ordinanza di rinvio a giudizio ove si spiega che l’autore “lungi dall’esprimere giudizi negativi su quell’esperienza politica ne rimarcava la validità”. Questo senza neanche aver letto il libro, perché queste notizie, come si legge nella stessa ordinanza, sarebbero “secondo quanto appreso dagli investigatori sulle recensioni allora apparse in rete”.
(5) Nel libro Claudia Mazzucato dedica una lunga parentesi a Manlio Milani, fondatore e presidente della Casa della Memoria di Brescia) ma al di là delle giuste e amareggiate considerazioni sull’alone di mistero giudiziario che ancora avvolge queste stragi, non una parola su Gladio, la loggia P2, Stay-behind, le manovre governativo-golpiste, che pure tanta parte ebbero nelle vicende di quegli anni. Suggeriamo al lettore curioso un libro recente: Gabriele Fuga – Enrico Maltini, Pinelli. La finestra è ancora aperta, Colibrì, Milano, 2017. Gli autori basano buona parte delle loro considerazioni sui documenti dei servizi “ritrovati” nel 1996 e messi a disposizione (conservati e ordinati) proprio dalla Casa della Memoria di Brescia nel 2011. Nel frattempo, il 20 giugno scorso, è giunto a sentenza definitiva il processo per la strage di Piazza della Loggia, con la condanna all’ergastolo per Carlo Maria Maggi, ai tempi ispettore veneto dell’organizzazione neofascista Ordine Nuovo, e di Maurizio Tramonte, allora fonte “Tritone” dei servizi segreti.
(6) Nelson Mandela, Lungo cammino verso la libertà, Feltrinelli, Milano, 2007.
(7) Va detto che dalle note si apprende che il testo riprende un precedente lavoro dello stesso Ceretti “intorno alla Commissione per la Verità e la riconciliazione sudafricana” e che è quindi dedicato a un tema che gli stessi Autori definiscono “non assimilabile”; però qui l’argomentazione è più che “assimilata”, con tanto di riferimenti ad Hannah Arendt: “crimini che per la loro devastante distruttività non si possono né punire né perdonare”. Suvvia, cerchiamo di non esagerare…
(8) Adolfo Ceretti, “Lotta armata, vittime, conflitti e dissidi. Un’ultima ricognizione”, in Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, il Saggiatore, Milano, 2015.
(9) Vedi, p. es., p. 148.
Nils Christie, I conflitti come proprietà
https://www.inventati.org/apm/abolizionismo/articoli/christieDEF2.pdf
APM, La pentola e i coperchi
APM, Bibliografia sulla Lotta Armata
https://www.inventati.org/cope/wp/wp-content/uploads/2015/12/20_Biblio_scelta_la.pdf